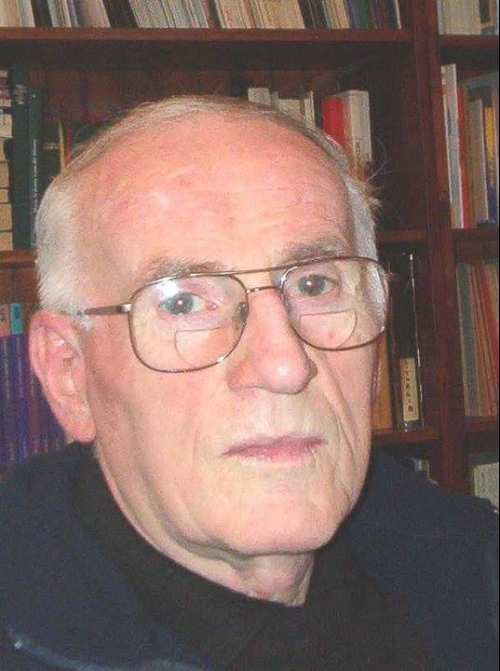La regola che fissa la data della Pasqua cristiana fu stabilita nel 325 d. C. dal Concilio di Nicea. La Pasqua cade la domenica successiva alla prima luna piena dopo l’equinozio di primavera (21 marzo). Dalla Pasqua si calcola il mercoledì delle Ceneri e quindi il Carnevale. Dite la verità: siete rimasti “alla prima luna piena…”? Anche io. :O)
Ogni anno, a Bagolino, la tradizione rivive. Vorrei che questo verbo, “rivivere”, fosse colto nel suo pieno significato. Già, perché dal 1500 ad oggi, quello che potete assaporare nel nostro borgo non è un forzato scimmiottare la vita di un tempo, ma è il mantenere una continuità con il passato; una continuità che non si spezza, sostenuta da un elemento originale, spontaneo che, se falsato, ti fa pagare pegno, ti smaschera: la trazione orale. Questo evento non si svolge solo a Bagolino, ma anche a Ponte Caffaro, frazione sul Lago d’Idro (tredici chilometri di distanza e una rivalità secolare!).
Se ascoltate attentamente le musiche del Carnevale di Ponte Caffaro (che poi sono le stesse), le sonorità sono diverse e, in alcuni casi, anche il modo di ballare. E vi chiederete come sia possibile. E’ la forza della tradizione orale! Immaginatelo così: nel 1500 c’è un tale. Lo invento, si chiama Tonino. Suona il violino e sa a memoria tutte le ballate. Volete che, scendendo a valle perché si è sposato una caffarese, in 20 anni, senza uno spartito, non abbia cambiato una nota? Beh, colpa delle donne, direte! Forse… Ma forse ci sta anche che un giorno, Tonino, senza una traccia, abbia deciso che una nota gli piacesse di più di quell’altra. Le sonorità cambiano così, spontaneamente, nel tempo. Figuriamoci in più di cinquecento anni (nell’archivio comunale di Bagolino, uno dei più completi d’Italia, si testimonia che il carnevale fosse già presente nel XVI secolo. Si pensa, quindi, sia molto più antico). Il fatto di trovare diversità non è una mancanza, ma un plusvalore, la garanzia dell’autenticità di questo evento.
Cosa attira l’attenzione del visitatore che giunge a Bagolino? Credo, semplicemente, i ballerini, i màscär, la gastronomia, la bellezza del territorio e… la musica.
Quando “parte” la musica, non importa che tu sia uno spettatore; col pensiero balli anche se non sai ballare. A suon di musica i foresti (già, se non siete del posto vi chiamiamo così) battono il piede per tenere il tempo! I bagossi? No, i bagossi no – già li vedo – sollevano entrambi i talloni e vanno sulle punte più in alto o più in basso a seconda della cadenza (bagossi, lo so che state ridendo!).
Se osservi la fila dal fondo, noti le ultime figure. Ferme, aspettano il proprio turno. E un libero pensiero sorge spontaneo: “Almeno si riposano un attimo! Sono stanca io che li guardo, figuriamoci loro!” No, no! La coppia rimasta alla fine prende sotto braccio qualcuno tra il pubblico e gli “fa fare una ballata”. Le vesciche ai piedi, prima o poi, passano. Appunto, prima o poi. Ora si balla! Alle vesciche penseranno domani…
C’è un momento che vi vorrei raccontare ed è quello finale. Direte: non ci hai spiegato quando e come ballino e parti dalla fine? Beh, sì, inizio dall’Ariòzä. E come dice la parola è proprio ariosa nel senso che, oltre ad essere allegra, è l’unica che concede molto spazio ai protagonisti; si esegue in cerchio, nella piazza principale del borgo, il lunedì e martedì sera, come ultima danza. E qui vi svelo un aneddoto che mi fa morire dal ridere. Penso che non ci sia anno in cui non ci “abbiamo fatto un ricamo”. Ad ogni carnevale, il capo ballerino decide l’itinerario (il capo è il capo e il nostro è insostituibile!) Quasi ogni volta viene modificato (magari solo in parte) e – si discute – se sia migliore del precedente. Tutto perché? Per fare l’ Ariòzä ad un orario decente. Puntualmente il gruppo è in ritardo e puntualmente ce la ridiamo (e non per colpa del capo!). Ti vengono pure a dire che erano in anticipo: e noi glielo lasciamo credere! Tanto lo sappiamo che, se mangeremo, non sarà che verso le ventidue e che faremo di tutto per gustarci l’ultima fetta di salame appena prima che il campanone suoni l’inizio della Quaresima (e con tutto quello che abbiamo mangiato e bevuto – qualcuno direbbe – se non ci riuscissimo, sarebbe meglio!). Abbiamo atteso un anno, un lungo anno prima di rivedere l’ Ariòzä: che ci costa un’ora in più o in meno?
La Piazza Marconi è luogo strano: non sembra nemmeno una piazza, forse perché storicamente non lo è mai stata. Ma quella sera, la sera del martedì di carnevale, l’agitazione si sente nell’aria e le case, come l’anima di uno strumento, sembrano contenere e amplificare tutta l’emozione. Si girovaga un po’. Si pensa dove attendere i ballerini, cercando la postazione ideale, anche quella più impensata. In effetti, impensato lo era il tetto della vecchia cabina telefonica qualche anno fa, lo è la copertura del distributore ora o le “scàndole”(tegole di legno) dei carri costruiti per l’occasione. E, mentre aspetti, ti fanno compagnia il freddo ed il buio, quel buio che le luci non riescono a vincere, puntate perennemente verso il basso, che ti ricordano che vivi in questo stupendo borgo medievale, dove le ombre non sono meno importanti della luce.
Finalmente dalla strettoia spuntano i primi ballerini. La gente li saluta e dà loro coraggio: “I-è lé ültime sgoladüre (sono gli ultimi sforzi)!”.
Pian piano si mettono in cerchio. Ora, vi porto dentro a quel “cerchio”, così è come se foste tutti in prima fila. Non sentitevi estranei: balleranno anche per voi. La calca delle persone preme da dietro. Vi indico ora una ragazza. Cerca di riconoscere il suo amore dal disegno del cappello. L’oro di famiglia vi è stato sapientemente puntato e cucito. In particolare cerca un anello, il suo. Lo riconoscerebbe tra mille. Non ha scelto la trama; non è ancora sposata. Il suo Ballerino è mascherato, perciò la vista è limitata. Lei lo sa e lo chiama: “Bälärì, Bälärì!” I ballerini non possono essere chiamati per nome. Non sente. Allora lei lo chiama più forte. Lo chiama, perché lì, in quel momento lì, anche se l’ha visto dieci minuti prima, vale di più. Anche l’Amore, in questo istante, vale di più. “Bälärì, Bälärì!” Ecco, lui si gira e la vede. La mano è ricoperta da un guanto bianco; la avvicina alla maschera e le manda un bacio. Lei alza il braccio ed è come se gli dicesse: l’ho preso! E sorride. Lui prende posto. Lei? Guardate i suoi occhi: lo segue con lo sguardo. Non lo distoglierà mai, nemmeno per un attimo.
E nella grande confusione di luci e colori, ecco, improvvisamente, un suono. Non un suono qualunque, ma il suono del contrabbasso: viscerale e profondo. Un richiamo che ci ha accompagnato per tutto il carnevale. Sapete, la notte, quando appoggiamo l’orecchio al cuscino, quando tutto è finito, lo sentiamo ancora… “re, la, re, re – sol, la, re”. Questo è l’istante in cui realizzi che un altro carnevale è passato, in cui sei certo che ne è valsa la pena aspettare e, soprattutto, che non c’è altro luogo in cui vorresti stare, perché quell’attimo basta all’eternità.
Non scriverò della danza. Vi invito a vederla. Posso dirvi, però, che due sono i momenti che amo: il primo, è infinitamente piccolo. E’ il vuoto, il silenzio, che precede la prima battuta dei violini. E’ il tempo di un respiro, talmente profondo che credi che l’universo lo stia prendendo con te. I ballerini alzano le braccia, si prendono per mano, le stringono fino a tremare. In un gesto, si crea il sigillo che chiude quel cerchio. In quel preciso istante, senti che quel cerchio è il mondo ed il mondo è in quel cerchio: è l’energia visibile di quel fulcro ancestrale che ogni giorno, ovunque ci troviamo, ci ricorda prima di tutto chi siamo.
Il secondo momento è l’abbraccio, quell’abbraccio che vedi nascere spontaneo tra i ballerini alla fine, dopo l’ultimo suono del contrabbasso. E’ il segno che tutto è come è sempre stato e in cui senti che anche chi non c’è più non è voluto mancare.

Foto di A. Nabacino, Album di Flickr di Monte Maniva http://www.flickr.com/photos/maniva/6755644771/in/set-72157625967167846
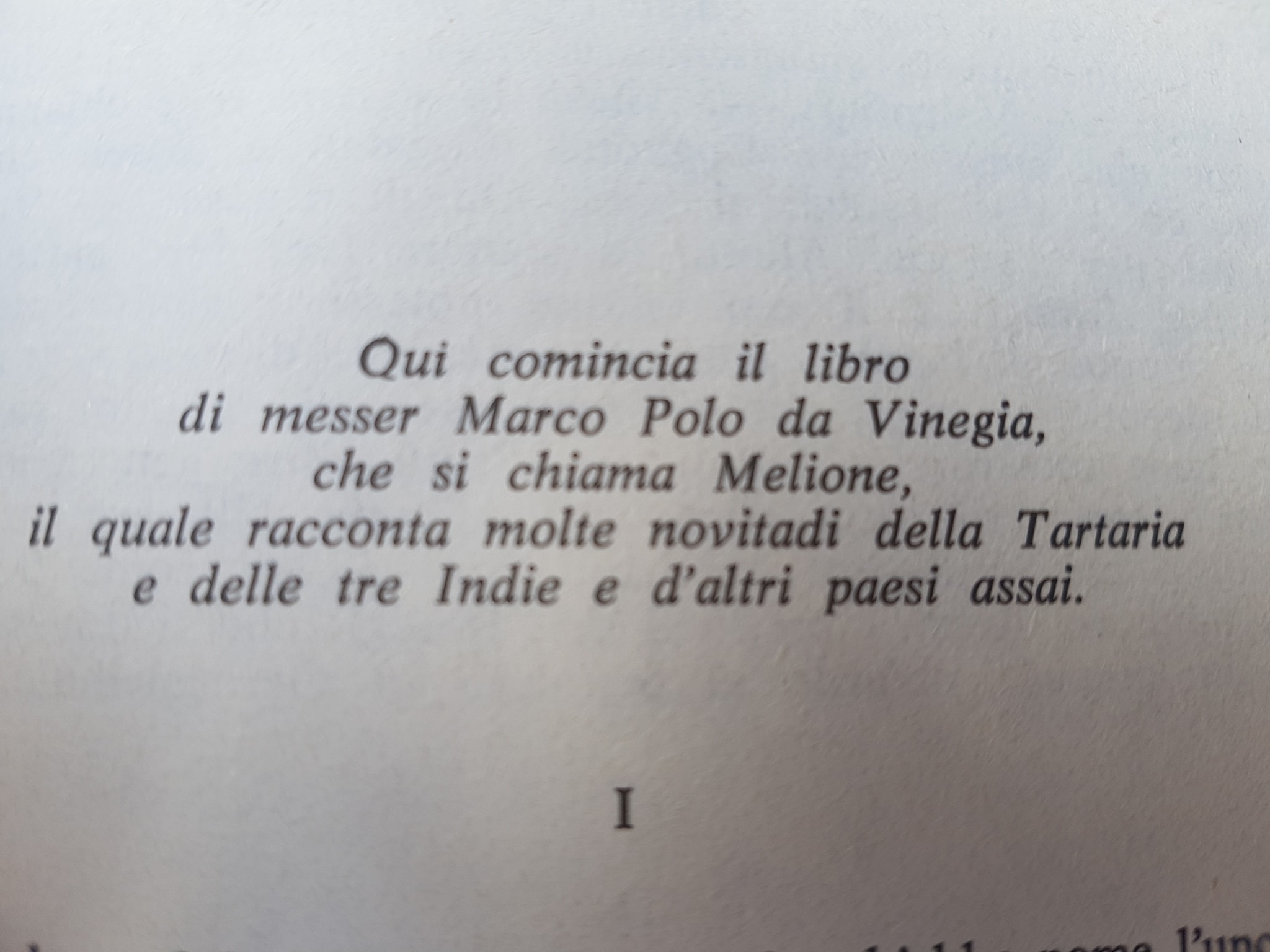 Una volta una signora mi disse che per stare bene avrei dovuto scrivere centocinquanta desideri e mettere una crocetta quando se ne fosse avverato uno.
Una volta una signora mi disse che per stare bene avrei dovuto scrivere centocinquanta desideri e mettere una crocetta quando se ne fosse avverato uno.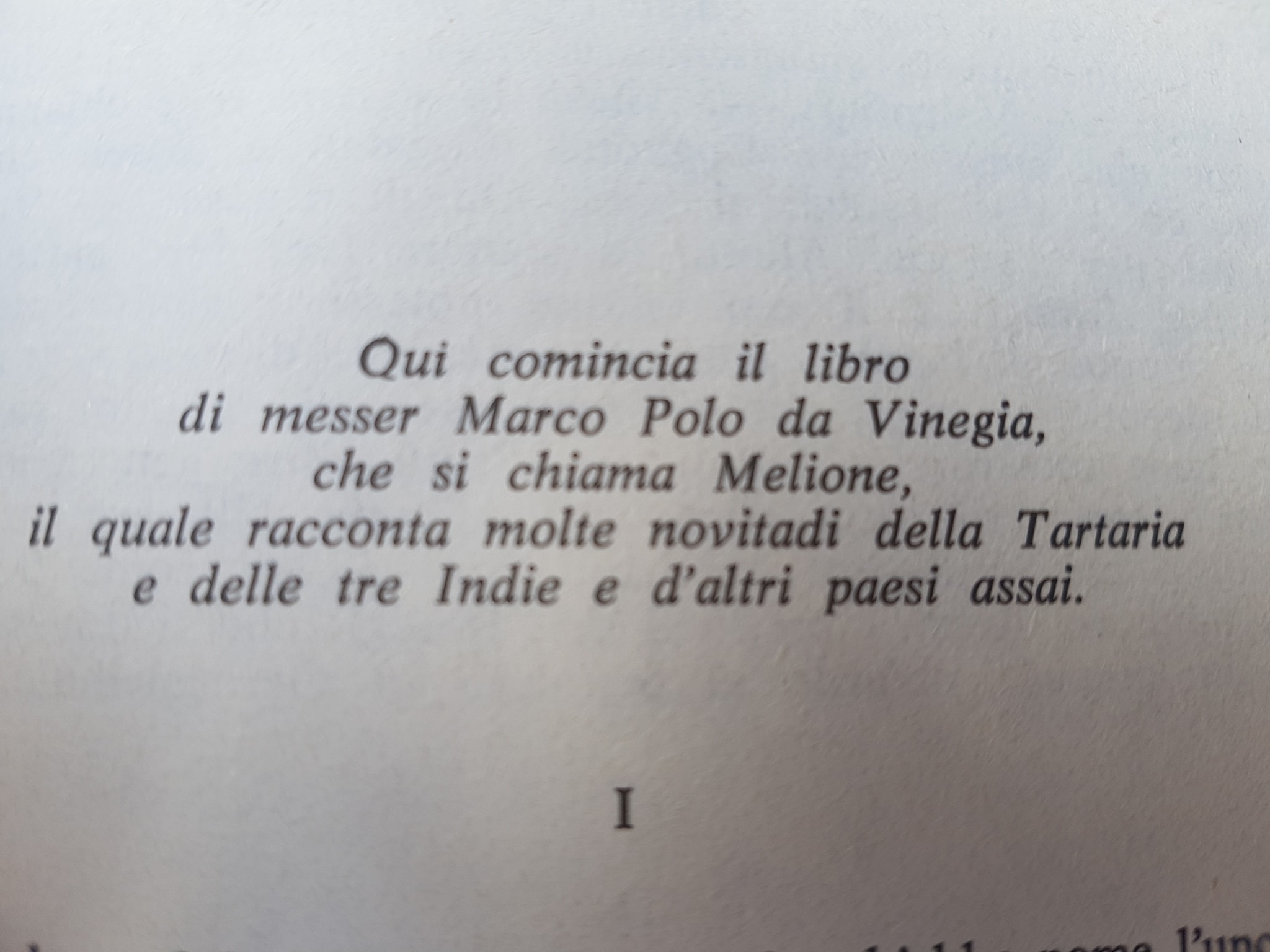 Una volta una signora mi disse che per stare bene avrei dovuto scrivere centocinquanta desideri e mettere una crocetta quando se ne fosse avverato uno.
Una volta una signora mi disse che per stare bene avrei dovuto scrivere centocinquanta desideri e mettere una crocetta quando se ne fosse avverato uno.